|
39 |
|
la recensione letteraria di intra i sass |
|
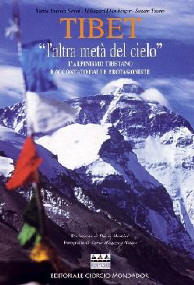 |
Titolo: L'altra metà del cielo |
L'altra metà del cielo recensione di Paola Lugo |
|
|
In attesa che la “montagna di libri” pubblicati per l'anniversario della
salita al K2 da parte degli italiani Lacedelli e Compagnoni ci sommerga,
può essere utile, per difenderci meglio dalle valanghe di rievocazioni
celebrative e di antiche polemiche, ripararsi dietro la lettura di una
storia diversa dell'alpinismo himalayano. La storia che i padroni di casa, tibetani e nepalesi, uomini e donne, stanno scrivendo sulle pareti delle
“loro” montagne. Conoscere l'attività alpinistica dei tibetani e in particolare delle sherpani, non è facile. Prima di tutto la complessa situazione politica del Tibet, che rende l'accesso alla regione tutt'altro che semplice, poi le difficoltà linguistiche e, in generale, la scarsa conoscenza, da parte di noi europei , della cultura himalayana, che spesso impedisce una corretta lettura dei fatti. Quando si viene colpiti dal “male del Tibet”, come è accaduto a Maria Antonia Sironi e a sua figlia Hilgergard Diemberger, però, può accadere che dopo anni di viaggi e pellegrinaggi fra monasteri e montagne, ci si ritrovi in un ristorante tibetano, a mangiare momo e chang e a bere vino italiano, con alpinisti e alpiniste del luogo. E allora “fu come fossimo in un rifugio e ci conoscessimo da sempre”. Da questi incontri è nata l'idea del libro “Tibet, l'altra metà del cielo”, scritto a più mani con la collaborazione di Sonam Tsomo, direttrice del Tibet Mountaineering Department. La stesura del libro viene definita da Maria Antonia Sironi “una affilatissima cresta di ottavo grado irta di ostacoli e sospesa fra profondi abissi”, data la difficoltà sia di recuperare il materiale, sia di interpretare correttamente gli appunti e le interviste prese. In primo luogo gli alpinisti tibetani sono tutti alpinisti di stato, ovvero salgono per professione, dopo essere stati scelti ed addestrati dall'organizzazione alpinistica ufficiale, la ridzigtshokpa. Una volta giunti in vetta spiegano al vento la bandiera rossa a cinque stelle dello stato cinese, in una cerimonia che , a prima vista, è terribilmente simile ai riti nazionalistici delle grandi spedizioni europee. Non solo: per salire in vetta occorre essere membri del Partito Comunista, e si può ricorrere anche ad una ammissione in condizioni limite, quando le circostanze lo richiedono. La foto della cerimonia a 8.200 metri di Phantog, giovane alpinista tibetana, è una testimonianza esemplare. Ma, come dicevamo prima, fermarsi all'apparenza, non porta molto lontano, e leggendo il libro, esce un'immagine tutt'altro che scontata. L'alpinismo “di stato” cinese per molte ragazze, più che una sconfitta della propria identità, è stato un mezzo importantissimo di emancipazione sociale, la possibilità di affrancarsi da una dura condizione di lavoro nelle campagne, per vivere una grande avventura. E se sono cittadini cinesi, gli alpinisti non dimenticano le loro cultura: giunti in vetta ,a fianco della bandiera rossa, sventolano le bandiere di preghiera , e manciate di tsampa sono lanciate verso l'alto. Le donne, come spesso accade, sono diventate custodi della loro cultura, e dalle parole delle alpiniste tibetane emerge con forza l'amore per la loro terra, e una salutare mancanza di soggezione nei confronti dell'Occidente. Riferendosi alla spedizione tutta femminile allo Shishapangma a cui hanno partecipato alpiniste provenienti da nove paesi, tra cui il Tibet, Phurbu Dolkar commenta: «C'erano difficoltà di comunicazione, di linguaggio . Loro (le alpiniste occidentali) hanno dato l'impressione di pensare soprattutto a se stesse. Cosa, credo, dovuta anche alla differenza tra le nostre due culture. Io invece credevo che, legate alla stessa corda, tutte avremmo dovuto prendere cura le une delle altre». Questa intervista, insieme alle parole di Pemba Droma, che colpita dalla tormenta chiede perdono alla dea Chomolangma «perché non bisogna calpestare le cose sacre, soprattutto la Grande Madre», e solo dopo trova la forza per salire in vetta, credo possano essere un ottimo antidoto contro la retorica della conquista e dell'impresa che troppo spesso ingombra ancora oggi l'alpinismo occidentale. |
|
Paola Lugo |
|
|
copertina
Antersass copyright© 2004 intra i sass all rights reserved - http://www.intraisass.it
|
|
