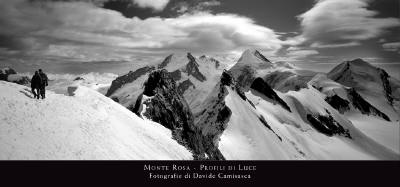Le splendide fotografie di
Davide Camisasca sul Monte Rosa si prestano a due letture diverse e, perché no?,
sovrapponibili.
La rinuncia all'uso del colore e la scelta di privilegiare le immagini in bianco
e nero suggeriscono un'interpretazione che si affaccia alla dimensione del
fantastico e dell'immaginario. O anche solo sempli-cemente alla storia
dell'esplorazione del massiccio. Osservando alcuni degli scatti della mostra, ad
esempio, è inevitabile chiedersi quali particolari rimasero impressi sulla
retina dei primi esploratori abbarbicati alla balconata della Entdeckungsfels,
la Roccia della scoperta, nell'estate del 1778. Ghiaccio? Roccia? Orizzonti
lontani? Otto anni prima della nascita ufficiale dell'alpinismo, Joseph e
Valentin Beck, Etienne Lisco, Joseph Zumsetin, François Castel de Perlatoe,
Nicolas Vincent e Sebastiano Linty, i sette giovani walser di Gressoney spintisi
fin oltre i 4000 metri, su quello che oggi è noto come Colle del Lys, non
ambivano affatto a scalare la vetta del massiccio. Cercavano la Valle Perduta
degli antenati, la mitica terra paradisiaca presente in tutte le leggende che
circolavano nei villaggi walser disseminati ai piedi del Monte Rosa (la famosa
guarde allemande, secondo Horace-Bénédicte de Saussure). Finiti gli
ultimi salti del Grenzgletscher, allungando lo sguardo oltre il ghiacciaio del
Gorner, videro praterie verdeggianti e armenti al pascolo. Pensavano di aver
valicato la soglia d'accesso di un altro mondo, e invece, come in uno specchio,
trovarono la copia di se stessi. Perché la gente che abitava dall'altra parte
del Rosa era la loro stessa gente, e i villaggi che di lassù si intuivano in
lontananza erano altri villaggi walser. Alla fine dell'esplorazione, quando si
sparse la voce della vicenda, per i valligiani abbarbicati ai versanti cisalpini
del Monte Rosa la gigantesca montagna ghiacciata cessò davvero di essere un
ostacolo e divenne un tramite, un ponte capace di riunire idiomi, culture e
idee.
Le foto di Camisasca però – lo abbiamo detto – non sono solo evocatrici di miti
e leggende. Le splendide vedute del Monte Rosa che compongono questa mostra si
prestano anche a un'interpretazione diversa. Dietro il mirino della macchina
fotografica, infatti, si indovinano l'occhio e la sensibilità dell'alpinista e
della guida alpina; i canoni estetici di chi è abituato a fare i conti con la
montagna sul terreno della pratica, a misurare pendii e pareti con la fatica
della progressione in cordata, a valutare la bellezza di una cresta, di un
pilastro, di una seraccata con criteri tutt'altro che astratti. Per forza di
cose, l'immaginario di chi frequenta la montagna è diverso da quello di chi non
è mai entrato in intimità con l'alta quota. La forma di una cornice, gli
accumuli di neve modellati dai capricci del vento, una cascata di seracchi o una
placca di roccia assumono valenze diverse se si possiede la chiave d'accesso
all'ambiente. Spellarsi le nocche sulle labbra di una fessura o penare lungo un
ripido canale ghiacciato non è solo una sequenza di movimenti tecnici né, tanto
meno, un esercizio sportivo. L'affaccio sul vuoto e l'incontro ravvicinato con
la montagna sono un'esperienza da cui difficilmente si esce indenni. L'intimità
con il mondo delle alte quote – e il Monte Rosa, in questo senso, è davvero l'Himalaya
dell'arco alpino – lascia spesso il segno. Una scalata lassù regala momenti
irripetibili e a volte costringe a modificare il proprio sguardo nei confronti
del mondo. Frugando tra i ghiacci e ascoltando il respiro della montagna, si
rischia di trovare se stessi. Esattamente come capitò duecentoventiquattro anni
fa ai sette gressonari saliti nel cuore del Rosa alla ricerca della Valle
Perduta, ignari che lo Shangri-La delle Alpi stava proprio sotto i loro piedi.